
1863-1938
bio
Nato a Pescara il 12 marzo 1863, Gabriele D'Annunzio si trasfer? a Roma dove inizi? ma non concluse gli studi alla facolt? di lettere. Visse all'insegna dell'estetismo e del decadentismo, sempre alla ricerca di nuove sensazioni in nome di un compiaciuto erotismo cui rimase fedele fino alla fine con ossessive varianti. Tra scandali, pose estetizzanti, relazioni con nobildonne e personaggi famosi del tempo, tra cui Eleonora Duse, si compone la ?vita inimitabile? di D'Annunzio.
Si ritir? poi nella villa La Capponcina, a Settignano: finch? i creditori gli sequestrarono la villa. Sdegnato, e per sfuggire ai creditori, D'Annunzio si ritir? ?in volontario esilio? in Francia. Tornato in Italia allo scoppio della guerra, divenne interventista acceso, e combattente valoroso. Tra le sue imprese guerresche furono la 'beffa di Buccari' (10 febbraio 1918) e il volo su Vienna (9 agosto 1918) con il lancio di volantini tricolori sulla citt?. Viene ferito a un occhio.
Dopo la guerra fu l'ideatore e il comandante della marcia da Ronchi a Fiume: occup? Fiume dal 1919 al 1921, con un pugno di volontari, proclamandovi una sua reggenza. Fu sloggiato dalle truppe italiche.
Ritiratosi a Gardone-Riviera [Brescia], in una villa da lui chiamata "Vittoriale degli italiani", guard? con favore al fascismo. Mor? dopo un lungo periodo di splendido ma patetico isolamento, a Gardone nel 1938.
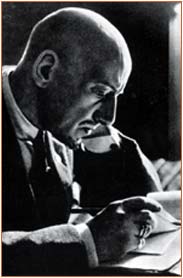
opere
D'Annunzio debutt? giovanissimo con la raccolta di versi Primo vere (1879), cui segu? nel 1882 Canto novo , che usc? con la co pertina disegnata da F.P. Michetti, e nel quale ? evidente l'imi tazione di Carducci, temperata da una vena sensuale e naturalistica.
Dall'estetismo europeo assimil? ideali di sensibilit? e raffinatezza e il gusto del tecnicismo formale. Nacquero cos?, accanto a alcune raccolte di versi, i romanzi: Il piacere (1889), Giovanni Episcopo (1891), e L'innocente (1892). Soprattutto negli ultimi due si pu? avvertire la lezione di Tolstoj e di Dostoevskij, ma ridotta da studio del profondo a languida ostentazione del morboso.
"Il piacere" ? ambientato in una Roma di lusso, tra papale e umbertina. Protagonista ? il conte Andrea Sperelli, ?ideal tipo del giovine signore italiano del sec.XIX [...] legittimo campione di una stirpe di gentili uomini e di artisti eleganti?, la cui massima ? ?bisogna 'fare' la propria vita come si fa un'opera d'arte?. Poeta, pittore, musicista dilettante, ma soprattutto raffinato artefice di piacere, egli ha stabilito la sua dimora nel palazzo Zuccari a Trinit? de' Monti: passa le sue giornate tra occupazioni mondane, si circonda di persone eleganti e di oggetti preziosi, lontano dal ?grigio diluvio democratico [...] che molte belle cose e rare sommerge miseramente?. Andrea ? tormenta to dal ricordo di una relazione complicata e sensuale con l'enigmatica Elena Muti, bruscamente troncata dall'improvvisa partenza della donna da Roma. Dopo un breve periodo di isolamento, si tuffa in una nuova serie di avventure, finch? un rivale geloso lo sfida a duello e lo ferisce. Si abbandona a una convalescenza ?purificatrice? nella villa di una ricca cugina, a Schifanoia. Qui conosce una creatura casta e sensibile, Maria Ferres, moglie di un ministro del Guatemala. Per lei si illude di avere un amore spirituale, ma presto il loro rapporto si intorbida e nel contat to con Maria cerca di riprodurre le sensazioni gi? provate con Elena, sovrapponendo le immagini delle due donne. Al culmine dell'amplesso, Andrea si lascia sfuggire il nome dell'antica amante: Maria fugge inorridita.
"L'innocente" ? la confessione di un delitto, esposta in prima persona dal protagonista. Nuova incarnazione del ?superuomo? l'ex diplomatico Tullio Hermil tradisce cinicamente la moglie Giuliana relegandola al ruolo di sorella e consolatrice. Solo dopo aver interrotto una burrascosa relazione con la possessiva Teresa Raffo, ? assalito da un'ansia sconosciuta di pace e di dolcezza co niugale. Ma si insinua in lui il sospetto che Giuliana lo tradi sca con uno scrittore alla moda, Filippo Arborio. E' l'antefatto. Seguono 51 brevi capitoli in cui la vicenda, piuttosto scarna, viene sostenuta da indugi psicologici, torbidi fantasticamenti, descrizioni di ?atmosfere?. Soffocato il dubbio che lo angoscia, Tullio va a vivere in campagna, nella casa materna. Un giorno, a Villalisa, la dimora in cui ha trascorso felicemente i primi anni di matrimonio, ritrova pieno e inebriante l'amore della moglie. Poco dopo la rivelazione: Giuliana in un momento di debolezza l'ha realmente tradito e attende ora un figlio concepito con Fi lippo Arborio. Sentimenti contrastanti nell'animo di Tullio: con sapevole di essere lui il vero responsabile del tradimento non pu? perdonare colei che infinite volte lo perdon?. Prova anzi per Giuliana una passione nuova, morbosa, mista di rabbia e di piet?. Vorrebbe sfidare Arborio a duello, ma lo scrittore ? stato colpito da paralisi [!] per cui questo sfogo ? impossibile. Nella sua mente sconvolta matura l'idea del delitto. Sopprimere il nascitu ro, unico ostacolo alla sua felicit?. Anche Giuliana, pi? che mai innamorata del marito, sfinita da una gravidanza dolorosa, accetta tacitamente l'atroce soluzione. Il bimbo nasce, odiato da Giu liana e da Tullio, ma protetto dalle cure dell'ignara nonna e del padrino Giovanni di Scordio, un contadino fedelissimo di casa Hermil. Una sera, mentre tutti i familiari si sono recati alla novena di natale, Tullio sacrifica l'?innocente? esponendolo al gelo invernale.
Dalla stessa vena estetista nacquero i versi del Poema paradisiaco (1893) che anticipa in modo notevole, soprattutto dal punto di vista della versificazione, modi che saranno tipici della poesia crepuscolare.
Nel periodo immediatamente successivo D'Annunzio volle colmare un vuoto morale, di cui egli stesso avvertiva il rischio, con il mito del ?superuomo? desunto da Nietzsche. Solo che alla "volont? di potenza" teorizzata dal filosofo tedesco, nel quadro di una distruzione della morale comune e di una rifondazione, D'Annunzio sostitu? ideali estetizzanti, destinati a comporre l'abbagliante mosaico di una ?vita inimitabile?. Appartengono a questo periodo i romanzi Il trionfo della morte (1894), Le vergini delle rocce (1895), e Il fuoco (1900). E i drammi La gloria (1899), e La cit t? morta (1899) e La Gioconda (1899) scritti durante la relazione con Eleonora Duse.
Nel periodo di 'ritiro' nella villa di Settignano scrisse al cune delle sue opere maggiori: i primi tre libri ("Maia", "Elet tra" e "Alcyone") delle Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi , che fu poi pubblicata nel 1903. E le tragedie Francesca da Rimini (1902), La figlia di Jorio (1904) , La fiaccola sotto il moggio (1905), La nave (1908), Fedra (1909), Pi? che l'amore , e il romanzo Forse che s? forse che no (1910).
"La figlia di Jorio", edita con frontespizio di A. De Carolis uno dei pi? innovativi disegnatori del tempo che collabor? per molte delle opere di D'Annunzio contribuendo a caratterizzare in maniera visiva i suoi libri (aspetto questo su cui D'Annunzio te neva particolarmente) e stampato dal solito Treves, che fu l'edi tore di D'Annunzio, ? una tragedia in tre atti, in versi sciolti. La vicenda si immagina ?or ? molt'anni? in terra d'Abruzzo. In casa di Lazaro di Roio si festeggiano le nozze del pastore Aligi con Vienda di Giave, quando sopraggiunge Mila di Codra, la putta- na dei campi figlia dello stregone Jorio, inseguita da una folla di mietitori ?briachi di sole e di vino?. Le donne incitano Aligi a scacciarla, ma Aligi, aiutato dalla sorella Ornella, la protegge perch? ha visto piangere l'?Angelo muto? simbolo dell'innocenza. Preso da un mistico amore, il trasognato giovane lascia la casa e la sposa per andare a vivere con Mila, in castit?, sulla cima della montagna. Vorrebbe andare a Roma a chiedere al papa l'annullamento delle nozze non consumate. Ma un giorno sale al loro rifugio Lazaro, il torvo padre di Aligi, che vuole possedere Mila con la forza. Il figlio si oppone, e lui lo fa legare e por tare via dai suoi contadini. Si getta poi brutalmente sulla don na. Aligi, liberato dall'ignara Ornella, riappare sulla soglia: sconvolto dalla scena che vede, uccide Lazaro. Il popolo condanna il parricida a morire affogato, chiuso in un sacco con un mastino. Ma Mila si accusa del delitto e giura di aver stregato l'amante inducendolo a credersi colpevole. Aligi la smentisce, ma poi, smemorato da un narcotico somministratogli, si lascia convincere e maledice la ?strega?. Tra gli urli e gli insulti della folla, Mila viene trascinata al rogo. Solo Ornella che ?sa?, perch? ?ha visto?, ha piet? di lei e la chiama ?sorella in Ges??.
Il titolo del romanzo "Forse che s? forse che no" riprende un motto pi? volte ripetuto all'interno del labirinto che decora il soffitto del Palazzo Ducale di Mantova. E' il segno dell'ambiguit? che lega i protagonisti. Paolo Tarsis ? un aviatore (siamo nel 1910 e essere aviatori era qualcosa di estremamente esotico e curioso), un tipo volitivo ma schiavo dell'amore sensuale di isa bella. Vana, sorella di Isabella, vergine scontrosa e ultrasensi bile, ama a sua volta Paolo appassionatamente. Tra Isabella e il fratello Aldo c'? una intesa segreta e esclusiva, che turba for temente Paolo. Vana, gelosa di Paolo come pure dei fratelli, de nuncia a Paolo un rapporto incestuoso tra Isabella e Aldo. Paolo nonostante l'orrore, non sa per? staccarsi dall'amante. Vanna si uccide. L'improvvisa, terribile pazzia di Isabella restituisce Paolo a s? stesso e ai suoi compiti di aviatore.
Durante l'"esilio" francese scrisse tra l'altro, in un prezioso francese, il dramma Il martirio di san S?bastien (Le martyre de Saint S?bastien, 1911) musicato da Debussy. E il quarto libro delle "Laudi" ( Merope , 1912) che raccoglie anche le Canzoni delle gesta d'oltremare celebranti la conquista italica della Libia. Al mito del superuomo tende ora ad affiancarsi il mito della super nazione, chiamata dal 'destino' all'impero.
Del 1916 ? il romanzo La Leda senza cigno .
Durante la degenza per la ferita all'occhio, in guerra, scrisse Notturno (1921), opera in prosa che caratterizza un momento di ripiegamento su s? stesso e contiene alcune delle sue pagine migliori e vibranti.
Nell'ultimo periodo della sua vita continu? a comporre opere, per lo pi? rievocative e autobiografiche: Il venturiero senza ventura (1924), Il compagno dagli occhi senza cigli (1928) ecc.
Tra le sue varie attivit? un certo posto occupa il suo interesse (pagato) per il cinema. Collabor? alle didascalie di "Cabiria" (1914) di Pastrone, di cui per ragioni di pubblicit? si assunse la paternit?. Non disdegn? altre collaborazioni, come quella a un film di propaganda come "Non ? resurrezione senza morte" (1922) fortemente anti-serbo e che vide la collaborazione di alcuni esuli montenegrini (la regina italiana era montenegrina). Anche suo figlio Gabriellino D'Annunzio, si dedic? al cinema.

la poetica
In D'Annunzio la giovane borghesia italica trov? la sua eva sione (sensualismo, estetismo) e il suo alibi (superomismo e supernazionalismo).
Nell'arte come nella vita la tensione eroica e superomistica ? prevalente, ma si scandisce in due fasi:
a) la prima ? caratterizzata da una effusa ?sfrenatezza? e si conclude con il poema autobiografico Laus vitae , in "Maia" (1903), che ? la trasposizione sul piano concretamente poetico dei motivi volon- taristici sparsi nei romanzi ("Le vergini delle rocce", "Il fuoco") e nelle tragedie ("La citt? morta", "La Gio conda", "La gloria");
b) nella seconda fase, durante e dopo l'esilio in Francia, prevale un superuomo che ?ricorda e del ricordo fa arte?. E' la resa e la negazione del superuomo. Un atteggiamento che si ri flette in alcune opere di teatro ("Pi? che l'amore", "Fedra"), e di narrativa ("Forse che s? forse che no", "La Leda senza cigno", "Notturno").
c) in mezzo a queste due fasi, tra questi due momenti conflittuali, c'? la grande 'tregua' di Alcyone , il capolavoro della poesia dannunziana. Qui cadono le intrusioni volitive e il canto si libera in pura mistica sensuale. Una poesia compiutamente de cadente perch? fatta solo di sensazioni e di atmosfera, in totale assenza di costruzione, di contenuti, di centri logici. Le punte pi? alte di questa lirica alcyoniana sono nella Sera fiesolana , Bocca d'Arno , Pioggia nel pineto , Stirpi canore .
Nella sua vasta opera D'Annunzio tent? in ogni modo e con ogni espediente di realizzare la fusione tra arte e vita che fu il sogno di tanti artisti decadenti. In lui era anche un proposito di europeizzare una cultura provinciale come quella italiana di allora. La sua grande forza assimilatrice e mimetica ? per? disponibilit? a tutto, un congenito e patologico vuoto di problemi e di istanze. L'aspetto pi? valido della sua opera ? nella magi strale abilit? a esprimere la comunione di sensi e d'animo con il tutto, le suggestioni di una sensualit? rapida ?fuori dei sensi?. E' il "panismo" dan- nunziano, la capacit? di rivivere in s? la vi ta della natura, il momento del dissolversi dell'io, l'affacciar si di un rapporto non effabile per via logica con le cose. Da vate alla Carducci il poeta diventa veggente: da guida della storia decifratore dell'ineffabile interiore. In questo mondo esplorabi le solo con gli strumenti dell'intuizione D'Annunzio penetr? con un pesante bagaglio di retorica: gran parte delle sue pagine sono immense macchine di ostentazione dove regna la ?parola come fine?.
D'Annunzio ha lasciato una innegabile, anche se non essenziale, lezione su tutta la prima met? del secolo letterario italico. Oggi le (poche) pagine pi? leggibili della sua produzione sono in quelle intimiste, "notturne", e nello splendore formale di un linguaggio analogico che esprime per suggestione pi? che per comunicazione
fonte: antenati

Bibliografia:
Gabriele D'Annunzio
Primo vere (1879)
Canto novo (1882)
Il piacere (1889)
Giovanni Episcopo (1891)
L'innocente (1892)
Poema paradisiaco (1893)
Il trionfo della morte (1895)
Le vergini delle rocce (1895)
La citt? morta (1899)
La gloria (1899)
La Gioconda (1899)
Il fuoco (1900)
Francesca da Rimini (1902)
Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi (Treves 1903)
La figlia di Jorio (Treves 1904)
La fiaccola sotto il moggio (1905)
La nave (1908)
Pi? che l'amore
Fedra (Treves 1909)
Forse che s? forse che no (1910)
Le martyre de Saint S?bastien (1911)
Merope (1912)
La Leda senza cigno (1916)
Notturno (Treves 1921)
Il venturiero senza ventura (1924)
Il compagno dagli occhi senza cigli (1928)

link:
http://www.gabrieledannunzio.net/
http://www.cronologia.it/storia/biografie/dannunz2.htm
http://www.italialibri.net/autori/dannunzio.html




